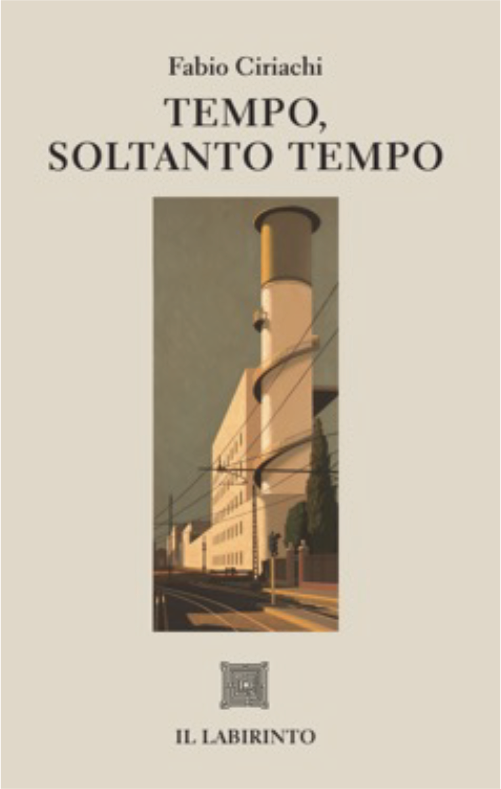Tempo, soltanto tempo
- Categoria: I nostoi
- Autore: Fabio Ciriachi
- Pagine: 128
- Prezzo: € 14,00
- ISBN: 9791281124028
- Anno: 2023
«Tempo, soltanto tempo è una piccola casa di pietra a vista che decora, nei limiti dell’edilizia rurale, il versante selvaggio della poesia italiana in cui, per indole, mi sono collocato. Molto simile a una terra collinare e appartata di quella Toscana prossima all’Umbria dove ho vissuto gran tempo in anni lontani decisamente fertili, e lunghi il giusto perché potessi seminare e veder crescere quella che, a tutt’oggi, è la mia benedetta pianta dello stare al mondo; una pianta che non smette di fiorire, benché avanti negli anni e, suggerendomi di fare altrettanto, anche nelle più sostenute bufere cronologiche oscilla instancabile fra nostalgia e riconoscenza, come se il pianeta in cui, attraverso me, ha messo radici meritasse sentimenti tanto profondi e nobili». Così l’autore dice di sé stesso - e di ciò che da testimone ha “raccolto” in questo libro - fingendo di concludere l’avventura della sua scrittura in versi. Fine narratore perché poeta, Fabio Ciriachi è un poeta che racconta: la sua cifra è costruire in silenzio. Noi già lo aspettiamo alla prossima prova – non importa se in versi o in prosa – nella convinzione che uno scrittore vero risponde sempre a pochi inauditi accordi, scrive sempre lo stesso parco libro.
Dal risvolto di copertina
In copertina: Mauro Reggio, Via Giolitti, 2005
Per concludere
A lungo ho trascurato il lavoro sui versi. L’impegno nella narrativa aveva preteso tempo ed energie; ero in ritardo sui progetti e dovevo provvedere prima che la vecchiaia complicasse troppo (concordo col Said di Sullo stile tardo, ma è meglio non esagerare).
È così trascorso un decennio durante il quale ho scritto poesie ma come se fossero incidenti che mi limitavo ad appuntare nello stato sorgivo. All’orizzonte, lontano, una raccolta che prima o poi avrebbe preso forma. La quarta, e anche l’ultima. Del resto, quando hai raccontato la fine, c’è solo l’indicibile.
A scorrere il file dove anno dopo anno ho messo insieme circa 150 testi, mi sono reso conto che quasi tutti sono poco fedeli a un certo andamento “in levare” del passato, come se l’indurirsi del mio sguardo sul mondo avesse esatto una lingua nell’ordine del disincanto.
Dopo tre raccolte segnate da un fedele oscillare attorno a solidi punti fissi, questa quarta e ultima diverge dalla linea delle precedenti, quasi mirasse a concedersi libertà particolari. Potrebbe sembrare un risultato voluto (l’importanza delle cose ultime è nota) se non fosse, invece, del tutto casuale.
All’inizio del mio lavoro coi versi, che posso datare intorno al 1981 – e per “lavoro” non intendo mera scrittura, che data dal 1960, ma riflessione sul rappresentare – e anche nel pieno dei problemi relativi alla messa in cantiere delle prime due raccolte, una tale libertà era così impensabile da sembrare proibita.
Ma la terza raccolta, Pastorizia – dove per difendere un’idea di bellezza dal mortifero sociale di allora, il poemetto d’apertura ricorre a un auto-imbruttirsi simile al controfuoco per fermare gli incendi – a vederla col senno di poi, grazie alla sua torsione prospettica contiene in nuce, alcuni annunci della svolta attuale. Indefinibili, nel dettaglio, e però capaci di riflettersi con buona evidenza nelle poesie di Tempo, soltanto tempo.
In che modo il lavoro sui materiali raccolti avrebbe fatto tesoro della nuova libertà? D’impulso, direi attraverso la creazione di un corpo verbale non teso alle ragioni dell’abbagliare. Non nascondo che, un tempo, questo traguardo abbia suscitato in me un certo fascino. Ne ignoravo i rischi. La breve cecità che la forte luce causa (lo so soltanto ora) trasforma in fede ciò che viene dopo e in leggenda ciò che c’era prima, ed è quanto mai sconveniente procedere costretti tra fede e leggenda.
Adesso che l’equazione tempo/energie suggerisce concretezza, miro a impossessarmi di una forma il più possibile mimetica del presente, quindi fondata sulla navigazione a vista, sull’uso di strumenti precari, e con gli alti e bassi derivanti da un procedere tanto estemporaneo quanto privo di alternative. Viviamo in una distopia che ci rifiutiamo di vedere se non trasferita di peso in un futuro indefinito che aiuti a togliercela da sotto gli occhi. Ma è nostra, ora.
Esigo inoltre, da ogni singolo testo, l’impegno a farsi sintesi fra il momento in cui ha visto la luce, e il lavoro necessario a renderlo pubblicabile; un lavoro quasi di pedagogia, vòlto a dotare la sua ignoranza originale degli strumenti necessari a farsi leggere senza bisogno di mediazioni oltre il faccia a faccia tra due verità dinamiche e indeterminate che domandano e rispondono al contempo, quali testo e lettore; entrambi considerati nello stato inevitabile della loro impermanenza.
Il che – sulla scia di riflessioni nate da un aforisma sull’arte di Konrad Fiedler “Non è vero che gli artisti debbano esprimere il contenuto di un’epoca: essi devono dare all’epoca un contenuto” – mi ha suggerito di considerare la raccolta come una sorta di diario del decennio 2011-2021 svincolato, però, dall’ordine cronologico e teso al confronto con qualcosa che riesco a definire solo approssimandomi al concetto di tempo debito.
Per tendere a questo risultato, ho dovuto non temere le deformazioni del silenzio quotidiano che nutrivano versi disinteressati sia al “virtuoso” perorare che al “vizioso” derivare; ambenti, piuttosto, a una medietà che fosse stupida abbastanza da non farsi né eccitare dai primi né deprimere dai secondi. Ho dovuto trovare un ascolto di parole che rintracciasse la musica dell’esistente e ne restituisse dissonanze e variazioni ma libere dagli ordini ai quali di solito le si obbligano.
Ho puntato molto su un dire teso a rivelarsi quasi fine a se stesso, anche se mai gratuito, soprattutto quando pretendevo che ogni singolo verso si facesse ritmo e basta, a prescindere dai valori propri sia dei versi che lo precedevano sia di quelli che lo avrebbero seguito.
E infine, ho cercato una lingua franta, antiarmonica che – obbligata a stare il più possibile nell’ordine dell’endecasillabo, benché solo quantitativo – salvasse dal rischio della piacevolezza facile e immediata. Guai, per me, se queste poesie potessero venir lette senza le fatiche di un procedere irto di ostacoli.
Avere chiesto alla raccolta l’onere di essere la mia ultima, fa di Tempo, soltanto tempo un momento topico del rapporto quarantennale con la poesia. Chiama in causa, in forme più icastiche e meno interlocutorie di una volta (prima o poi il morbido delle possibilità si esaurisce e resta l’arduo aut aut), l’etica e l’estetica, le poetiche e i maestri; senza darlo troppo a vedere, fa i conti coi portati biografici e con le visioni del mondo, con le correnti della critica e con la crisi dei canoni.
Ma soprattutto, congeda la querelle fra psicologia e fisiologia perché ho l’impressione che la mente coincida con l’intero corpo e, in quanto tale, il soggetto sappia sempre, con tutto il bagaglio conscio e inconscio, ciò che serve sapere di se stesso, oltre la ridda delle improbabili dinamiche tra spirito e materia; così come il “corpo che è anche mente” non deve più obbedire allo spreco energetico causato dalla superflua dicotomia alla quale, per inerzia, ho sempre obbedito.
Sullo slancio delle mie pretese intravedrei addirittura il tentativo di avvicinarmi a una liberatoria e infantile irresponsabilità: a un ‘basta’ rivolto alle ombre di maestri e tradizione, di tendenze e gruppi, di teorie che brillano fino a quando non confluiscono in una prassi che non si rivela mai all’altezza delle aspettative.
E basta anche al pleonasmo della scrittura di ricerca e della sperimentazione, basta con chi stila liste di proscrizione di parole non più usabili, e non si accorge che così facendo dà il colpo di grazia alle vittime dell’abuso anziché colpire gli abusanti, basta coi laboratori che promettono il nuovo come se il problema fosse il vecchio, e comunque lo fanno attraverso coordinate tanto poco utili a trovarlo, quanto più lo evocano quale fine ultimo.
A rendere ulteriormente motivata la decisione di affidare a Tempo, soltanto tempo il congedo dalla poesia scritta c’è il ritardo con cui ho iniziato a pubblicare; reso più consistente dal decennio perso per mia sola colpa (senza l’inesperienza in campo editoriale avrei potuto esordire alla fine degli anni Ottanta invece che dei Novanta), sicché dalla prima uscita, L’arte di chiamare con un filo di voce (1999), a ora sono trascorsi ventitré anni. Per un giovane sarebbe una misura del tutto insufficiente a fargli chiudere il ciclo compositivo; alla mia età direi che possono bastare.
Nell’arco di tempo coperto da queste quattro raccolte (mi accorgo che le dividono pause cronologiche crescenti, 1999, 2003, 2011, 2022), sono certo di avere espresso quanto avevo da dire in poesia; come so che se continuassi nella ricerca di un ulteriore dettato “che porti la mia orma la mia forma”, è probabile che mi ripeterei (poiché non esistono certezze, non chiudo la porta a ritorni di fiamma senili che, nel caso, limiterei alla frugalità quasi incorporea dei “pezzi sparsi”).
D’altronde, la faccenda va anche considerata dal punto di vista dell’autorevolezza. Il che mi fa porre una domanda cruciale e retorica: chi sarei, io, per mettere al mondo più raccolte di Sereni e di Montale (considero Diario del ‘71 e del ‘72 e Quaderno di quattro anni alla stregua di eccelsi insiemi di pezzi sparsi), tanto per riferirmi a due stelle fisse che non smetto di consultare? Se questo non fosse sufficiente, rimarrebbero gli interrogativi-chiave che mi sono sempre posto dopo la prima pubblicazione: sono sicuro che sto per aggiungere dati significativi a quanto già detto? Non nutro un’ansia di esserci a costo di ripetermi, magari anche meno utilmente di prima?
Sono così dubbioso circa l’opportunità di avere voluto aggiungere la mia voce alle tante presenti nel grande affresco della poesia italiana, da considerare una riuscita, e anche una grande rassicurazione ai miei dubbi, la sola prospettiva di potermi vedere assegnato, prima o poi (non è detto che debba accadere in vita), un posto fra i minori del mio tempo.
Sarebbe un bel modo di esserci perché i minori sono importanti. Come si potrebbe, senza la loro presenza, concepire lo spazio dei grandi? Come potrebbe il paesaggio in cui questi ultimi si muovono risultare complesso, in continuo divenire se non ci fossero le graduate voci dei minori a fare da controcanto, da eco, da cassa di risonanza? È anche grazie allo iato fra intenzioni ed esito tipico dei minori, che i grandi trovano spazio di relazioni col mondo della vita, e arrivano a “dire” nel modo durevole che li rende indispensabili e unici. Cosa sarebbe, della maestria, se i suoi pochi rappresentanti li immaginassimo collocati in un contesto deserto o abitato solo da altrettante rarità? Se fosse vero, insomma che in un secolo, di poeti, ne nascono tre o quattro?
In tal senso Tempo, soltanto tempo, come ultimo contributo al mio quadro d’insieme, è una piccola casa di pietra a vista che decora, nei limiti dell’edilizia rurale, il versante selvaggio della poesia italiana in cui, per indole, mi sono collocato. Molto simile a una terra collinare e appartata di quella Toscana prossima all’Umbria dove ho vissuto gran tempo in anni lontani decisamente fertili, e lunghi il giusto perché potessi seminare e veder crescere quella che a tutt’oggi è la mia benedetta pianta dello stare al mondo; una pianta che non smette di fiorire, benché avanti negli anni e, suggerendomi di fare altrettanto, anche nelle più sostenute bufere cronologiche oscilla instancabile fra nostalgia e gratitudine; come se, malgrado la nostra imbarazzante presenza, il pianeta in cui ha messo radici meritasse sentimenti tanto profondi e nobili.
Fabio Ciriachi